|
BOLOGNA: «Oltre la crescita esiste la SOSTENIBILITÀ dello sviluppo»
di Raffaella Venerando
Solo i Paesi che riusciranno a fornire la migliore qualità della vita ai propri abitanti riducendo la richiesta di risorse energetiche, agricole, ittiche, forestali, diventeranno i veri leader del futuro
La corretta gestione dei beni comuni della Terra (aria,
acqua, suolo, oceani, biodiversità) esige che si limiti
il volume dello scambio di materiali tra l'umanità e la biosfera in modo da non mandare in rovina l'economia della natura
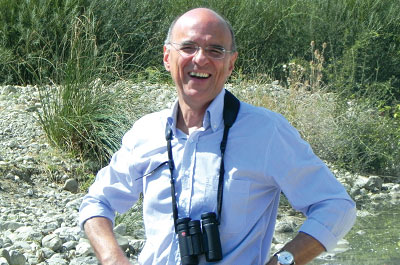
Gianfranco Bologna, direttore WWF Italia
Direttore Bologna, lei ha curato l'edizione italiana del libro "Blue economy" di Gunter Pauli, in cui si racconta delle migliori 100 soluzioni tecnologiche che imitano dalla natura alcune soluzioni capaci non solo di cambiare il mondo ma addirittura di creare occasioni di lavoro. Vuole fornirci qualche esempio pratico?
Il libro di Pauli "Blue Economy" è un rapporto al Club di Roma, lo straordinario think‑tank internazionale, fondato nel 1968 da Aurelio Peccei, figura dalle straordinarie qualità umane e intellettuali che ha avuto il merito di produrre rapporti importantissimi per il nostro futuro.
Il lavoro di Pauli scaturisce da un lungo e affascinante percorso avviato in questi ultimi decenni.
Infatti con il maturare della consapevolezza dei danni prodotti dal nostro intervento ai sistemi naturali abbiamo finalmente assistito a importanti cambiamenti nel modo di pensare al nostro ruolo nei metabolismi della natura.
Il volume di Pauli si ispira alla sfida straordinaria dei nuovi modelli di produzione e, come ci ricorda una delle figure pionieristiche della biomimetica, Janine Benyus nel suo volume "Biomimicry.
Innovation Inspired by Nature"edito da Harper nel 1997, «ci introduce in un'era basata non su ciò che possiamo estrarre dalla natura, ma su ciò che possiamo imparare da essa» (cfr. alcuni esempi concreti nella scheda a pagina 55).
Nel libro di Pauli emerge poi il concetto che la soluzione ai più diversi problemi è a portata di mano.
Basta scovarla e replicarla. È davvero così semplice e universalmente valida questa impostazione?
È evidente che non esistono risposte semplici a problemi molto complessi ed è altrettanto evidente che le frontiere della biomimetica necessitano di ricerca e innovazione e che queste, a loro volta, necessitano di impegno e capacità di visione.
Questa capacità di visione deve però appartenere anche al mondo politico‑economico. Pauli cerca infatti, nel suo volume, di far capire che la conoscenza scientifica prosegue e consegue importanti risultati, che è necessario investire in ricerca e sviluppo, far esplodere la creatività e l'inventiva e creare le condizioni economiche affinché tutto ciò possa diventare realtà operativa nei sistemi produttivi.
Pauli analizza in maniera chiara anche quali sono gli ostacoli che oggi si frappongono alla diffusione di queste innovazioni. In maniera avvincente e, mi auguro per tutti convincente, l'ideatore dell'economia blu dimostra anche come tali innovazioni siano le frontiere della nuova produzione "eco‑industriale" e "bio‑industriale" e dell'occupazione dell'immediato futuro.
I tempi sono quindi maturi perché la rivoluzione bio‑industriale sia concretamente realizzabile o manca ancora "qualcosa"?
Credo che, a livello di diversi paesi, ci sia una discreta maturazione del grande valore di questi ambiti di ricerca e che l'apparato politico ed economico produttivo inizi a rispondere in maniera positiva.
Certo, oggi siamo ancora agli inizi di questi promettenti settori. Si tratta di ambiti dove la ricerca è inevitabilmente interdisciplinare e dove appare sempre più evidente il legame tra chi studia la biodiversità e chi opera nel campo delle tecnologie applicate alla chimica e alla biologia: si tratta di una straordinaria frontiera di quella che molti definiscono la Sustainable Chemistry o Green Chemistry e che ancora necessita di maggiori precisazioni. Il nostro Paese, come noto, soffre invece di una drammatica carenza nel decidere e scegliere la centralità della ricerca, dell'educazione, della formazione, dell'innovazione e quindi nel fornire adeguati finanziamenti a questi settori.
In questo modo, al di là della puntuale registrazione di eccellenze, l'Italia rischia di non cogliere le straordinarie opportunità che si stanno presentando.
Ma cambiare nome e colore all'economia equivale a cambiarne la percezione? In che cosa differisce la
blue dalla green economy?
Ormai tutti, mi auguro, abbiamo imparato a comprendere che l'economia monetizzata non rappresenta affatto la nostra intera economia.
I sistemi e il capitale naturale sono indispensabili nel fornire numerosi servizi essenziali per la sopravvivenza e il benessere del genere umano.
Fino a poco tempo fa, purtroppo, la teoria e la prassi dell'economia centrata sulla moneta avevano di fatto rimosso questo aspetto vitale per tutti noi. Esse si sono basate per quasi duecento anni sul presupposto che la natura fosse a disposizione di tutti in un'abbondanza inesauribile.
Oggi questo assunto non ha più alcuna credibilità. Ormai come hanno dimostrato numerose analisi molto ben fatte come quelle del grande assessment internazionale, patrocinato dalle Nazioni Unite, definito The Economics of Ecosystems and Biodiversity (www.teebweb.org) e diretto dall'economista indiano Pavan Sukhdev nell'economia tradizionale la natura, di fatto, non partecipa al mercato.
Il suo contributo alla creazione di valore rimane sconosciuto e ignorato.
Di conseguenza anche il nostro atteggiamento culturale dominante che
investe tutti, dai politici ai decisori economici, è profondamente alterato perché il valore della natura non viene considerato. Come ricorda l'ottimo rapporto del Wuppertal Institut per il Clima, l'Energia e l'Ambiente, coordinato da Wolfgang Sachs (pubblicato recentemente da Edizioni Ambiente con il titolo "Futuro sostenibile") questo esito è contraddetto solo in parte dal fatto che il rame e l'uranio, il pesce o il legno si vendono ovviamente sul mercato a certi prezzi.
Questi prezzi infatti non riflettono il loro valore biosferico. Di solito si paga la quantità di lavoro e di capitale necessario per poter disporre dei servizi della natura. Le perdite inflitte alla capacità produttiva di quest'ultima non compaiono in nessun bilancio, né nazionale, né aziendale. Questi servizi della natura non esistono sui mercati, sottraendosi anche alla quantificazione monetaria.
È diventato quindi fondamentale un impegno chiaro e definito per dare valore concreto alla natura nell'economia e questo tema costituisce la base essenziale per costruire qualsiasi ipotesi attuativa della tanto declamata Green Economy, che costituirà uno dei due grandi temi centrali di discussione della Conferenza di Rio 2012 (l'altro riguarda le capacità di governance per attuare concretamente la sostenibilità).
La corretta gestione dei beni comuni della Terra (aria, acqua, suolo, oceani, biodiversità) esige che si limiti il volume dello scambio di materiali tra l'umanità e la biosfera in modo da non mandare in rovina l'economia della natura.
In linea di massima si tratta almeno di tre sfide: primo, stabilizzare il consumo delle materie prime su un livello con capacità di rinnovamento; secondo, mantenere le emissioni e gli scarti a livelli innocui o comunque sostenibili; terzo, lasciare la quantità di superficie utilizzata dagli esseri umani ad un livello compatibile con quella necessaria ai bisogni degli altri esseri viventi. Ovviamente non basta indicare un colore per rendere il sistema economico "verde" ma va fatta una profonda opera di "trasformazione culturale" per far comprendere appieno le componenti di una nuova economia che, finalmente, tenga in considerazione i sistemi naturali, metta in conto la natura e riconosca il valore del capitale naturale e dei servizi ecosistemici.
Oltre la crescita…che c'è?
La decrescita felice o cosa altro?
Non vi è alcun dubbio che un'economia basata su di una crescita materiale e quantitativa non sia più perseguibile da tutta l'umanità in futuro. Già oggi abbiamo raggiunto i 7 miliardi di abitanti e nel 2050, secondo i rapporti biennali delle Nazioni Unite "World Population Prospect", saremo più di 9 miliardi ai quali è impossibile garantire uno stile di vita consumistico quale quello classico dei paesi occidentali. Ormai è urgente predisporre strade alternative. Oltre la crescita esiste la sostenibilità dello sviluppo, ovvero uno sviluppo socio‑economico intelligente, capace di farci vivere entro i limiti biofisici di un solo pianeta.
Nel cosiddetto triangolo della sostenibilità, crescita economica, sicurezza sociale e compatibilità ambientale sono ancora considerati di pari importanza.
Ma questa equiparazione non riconosce la natura assoluta né dei limiti ecologici, né dei diritti umani. Per questo una politica della sostenibilità deve rispettare prioritariamente i limiti della capacità di carico degli ecosistemi. Solo a partire da lì verranno poi formulati i principi guida per l'economia e la sicurezza sociale, quasi come "guard‑rail" che impediscano alla civiltà umana di sconfinare negli spazi della natura.
Una simile rivendicazione di assolutezza spetta anche ai diritti umani: il dovere cosmopolita di garantirli non può essere compensao da altri obiettivi quali la competitività o la salvaguardia dei diritti acquisiti. Mantenere le dinamiche economiche all'interno dei "guardrail" del rispetto dell'ambiente e dei diritti umani è il programma centrale della sostenibilità. Come si può facilmente intuire il concetto di "decrescita" quindi è già perfettamente dentro il moderno concetto di sostenibilità.
Restando in tema di ambiente e sostenibilità, il WWF parla di impronta ecologica per i Paesi.L'Italia come è messa da questo punto di vista?
Ogni due anni, dal 1998, il WWF pubblica il "Living Planet Report" (LPR) un rapporto che fa il punto sullo stato del pianeta, utilizzando alcuni indicatori specifici (come l'impronta ecologica, l'impronta idrica e l'indice del pianeta vivente), e indica soluzioni per cambiare rotta.
Il Living Planet Report 2010 (scaricabile al sito www.wwf.it) analizza lo stato dell'indice del pianeta vivente, un indicatore che fornisce l'andamento di quasi 8.000 popolazioni, di più di 2.500 specie di animali vertebrati considerato dal 1970 ad oggi e la situazione dell'impronta ecologica che indica la quantità di risorse rinnovabili che utilizziamo nell'arco dell'anno (dai consumi alimentari derivati da agricoltura e pascoli al suolo trasformato per infrastrutture, alle foreste che servono per immagazzinare l'anidride carbonica da noi prodotta).
Il LPR 2010 ci dice che l'indice del pianeta vivente è sceso del 30% dal 1970 ad oggi e di ben il 60% nelle zone tropicali, mentre l'impronta ecologica dimostra che la nostra domanda di risorse naturali è raddoppiata dal 1966, tanto che oggi utilizziamo l'equivalente delle risorse di un pianeta e mezzo per soddisfare i nostri fabbisogni. In pratica i due indicatori ci dimostrano che rendiamo i nostri sistemi naturali sempre più deboli e vulnerabili, mentre continuiamo a crescere con la nostra popolazione e nella richiesta di energia, cibo, infrastrutture, suolo da trasformare. I 31 paesi della cosiddetta area OCSE (tra cui Italia e Stati Uniti) hanno un'impronta ecologica di quasi il 40% rispetto a
quella globale. Nei cosiddetti paesi BRIC è presente una popolazione doppia rispetto a quella dei paesi dell'area OCSE e il LPR dimostra che se non si cambia rotta al modello di sviluppo della crescita continua, la traiettoria seguita dalle impronte dei paesi BRIC presto sorpasserà quella dei paesi OCSE.
I paesi che riusciranno a fornire la migliore qualità della vita ai propri abitanti riducendo la richiesta di risorse energetiche, agricole, ittiche, forestali, diventeranno i veri leader del futuro. Tra i 10 paesi che hanno le maggiori impronte ecologiche vi sono gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar, gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia ma anche Danimarca, Belgio e Irlanda.
La maggiore impronta ecologica deriva dalla pressione esercitata sulle risorse rispetto alla biocapacità nazionale, cioè a quanto le singole nazioni sono in grado di soddisfare i propri consumi rispetto alla bioproduttività dei propri sistemi naturali.
Il rapporto, insomma, dimostra quanto sia valida e saggia l'osservazione secondo cui distruggere la natura vuol dire segare il ramo sul quale si è seduti. Non può esistere un "benessere" delle società umane e non possono esistere economie sane dei nostri sistemi sociali se distruggiamo le basi sulle quali poggia la nostra esistenza e il nostro sviluppo.
Si può incidere sulla riduzione di tale impronta in tempi brevi? In che modo?
Innanzitutto bisogna dare un "valore" alla natura. I nostri sistemi economici e di contabilità non considerano tutte le risorse della vita sulla Terra come una ricchezza dell'intera umanità.
Paradossalmente abbiamo
pensato di "fare cassa" distruggendo gli ambienti naturali e le specie che con noi condividono la biosfera, ma, purtroppo, ci siamo solo indebitati accrescendo un deficit con la natura che sta diventando ormai ingestibile. Le previsioni del LPR 2010 ci dicono che se continuassimo sulla strada della crescita economica attuale, entro il 2030 avremo bisogno di risorse rinnovabili equivalenti a due pianeti.
Ecco perché diventa importante affiancare una contabilità ecologica a quella economica classica; tutti i decisori politici devono essere consapevoli che il benessere non si raggiunge solo incrementando il PIL dei singoli paesi e quindi quello planetario, ma si raggiunge mantenendo la vitalità della natura e non certo distruggendola.
Lei ha più volte ribadito la verità dell'equazione benessere e salute dei sistemi naturali uguale benessere e la salute dei sistemi sociali.
Natura e cultura fanno oggi registrare segnali di degrado…inesorabile secondo lei? Come si corre ai ripari?
Con una grande operazione di trasformazione culturale. Il problema delle nostre relazioni con la natura è fondamentalmente un problema culturale. Per secoli abbiamo pensato che la natura costituisse una straordinaria cornucopia da cui attingere, come se fosse infinita. Oggi sappiamo molto bene che non è così. Dobbiamo imparare a vivere nei limiti di un solo pianeta e farlo in pratica risponde ad una grande sfida culturale, un'autentica rivoluzione culturale. Non possiamo più perdere tempo.
ESEMPI DI BIOMIMETICA
 - Le zanzare sono in grado di estrarci sangue senza causarci alcun dolore (escluso un gran prurito). Il segreto sta nella forma del pungiglione: di dimensioni infinitesimali e di forma conica, ossia più sottile in punta. Sostituita la forma cilindrica dell'ago ecco che si è realizzata una siringa indolore: la Nanopass 33 Syringe con un ago conico che in punta ha un diametro del 20% più sottile rispetto agli aghi convenzionali. Molto usata per i diabetici, che sono oltre 23 milioni nei soli Stati Uniti. Essendo gli aghi più sottili, c'è anche un risparmio di metalli. - Le zanzare sono in grado di estrarci sangue senza causarci alcun dolore (escluso un gran prurito). Il segreto sta nella forma del pungiglione: di dimensioni infinitesimali e di forma conica, ossia più sottile in punta. Sostituita la forma cilindrica dell'ago ecco che si è realizzata una siringa indolore: la Nanopass 33 Syringe con un ago conico che in punta ha un diametro del 20% più sottile rispetto agli aghi convenzionali. Molto usata per i diabetici, che sono oltre 23 milioni nei soli Stati Uniti. Essendo gli aghi più sottili, c'è anche un risparmio di metalli.
- Tra i batteri, gli animali e le piante sono moltissimi gli organismi in grado di depurare l'acqua. I pinguini sono uno tra i casi più straordinari: possiedono delle speciali ghiandole (dette ghiandole del sale, come avviene anche in altre specie di uccelli e rettili), poste sotto gli occhi, capaci di rimuovere l'eccesso di sale dall'organismo dovuto al fatto che bevono acqua di mare. Queste ghiandole funzionano in maniera simile ai reni umani ma sono molto più efficienti. Applicando questa "tecnologia naturale" si potrebbero "aumentare" le riserve di acqua a livello mondiale, depurando in maniera meno costosa le risorse idriche del Pianeta.
- Il mondo sottomarino ci offre un grande aiuto verso il risparmio energetico. Alcuni studiosi hanno analizzato il modo in cui le balene riducono la resistenza all'acqua e hanno cercato di applicare questa modalità al settore dell'energia eolica al fine di incrementarne la portanza. Le grandi pinne frastagliate delle megattere applicate nelle gallerie del vento hanno dimostrato di apporre meno resistenze e di incrementare la portanza rispetto alle pale lisce e dritte di aerei e generatori eolici.
- Le spugne marine hanno la capacità di creare vere e proprie fibre di vetro che trasmettono la luce in maniera più efficiente rispetto le nostre fibre ottiche, delle vere e proprie bio-lenti che minimizzano le distorsioni e ottimizzano l'intensità luminosa. Inoltre, sono molto resistenti e molto flessibili. Queste fibre più efficienti sono chimicamente poco complesse e quindi facilmente riproducibili. Ridurrebbero in maniera significativa l'impatto ambientale della comunicazione moderna.
|
