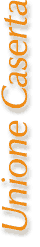
|
 Nel 1776 ebbe inizio la storia di San Leucio, definita "utopia di un re", cioè di un sogno che nel corso degli anni si è lentamente tramutato in realtà. Infatti, in un periodo di fondamentali cambiamenti politico-sociali che portarono all'Unità d'Italia, la Colonia di San Leucio diventò l'emblema del rinnovamento e della sperimentazione. Nel 1776 ebbe inizio la storia di San Leucio, definita "utopia di un re", cioè di un sogno che nel corso degli anni si è lentamente tramutato in realtà. Infatti, in un periodo di fondamentali cambiamenti politico-sociali che portarono all'Unità d'Italia, la Colonia di San Leucio diventò l'emblema del rinnovamento e della sperimentazione.
Nata per volontà di Ferdinando IV di Borbone, la Colonia di San Leucio acquisì nel tempo una sempre maggiore autonomia, rappresentando uno dei più alti esempi di assolutismo illuminato, estrinsecatosi nel Codice Ferdinandeo, che riassume il pensiero di un Re che, cresciuto in un periodo di grande fermento sociale, ha voluto sperimentare quelle idee di libertà ed uguaglianza che avrebbero ben presto cambiato per sempre il volto dell'Europa.
Ferdinando IV scelse quell'area perché "le delizie di Caserta e la magnifica abitazione cominciata dal mio augusto Padre e da Me, non traevano seco coll'allontanamento dalla città anche il silenzio, e la solitudine, atta alla meditazione ed al riposo dello spirito; ma formavano un'altra città in mezzo alla campagna, colle stesse idee di lusso e della magnificenza della capitale".
La Colonia si sviluppò intorno al nucleo delle 6 famiglie dei custodi del bosco di S. Silvestro, che fu recintato e nel quale vennero introdotte altre 17 famiglie. Fu elevata a parrocchia la piccola chiesa del Belvedere attorno alla quale fu dunque edificato l'opificio.
A capo della Colonia c'era un Sopraintendente Generale incaricato della direzione della fabbrica. La contabilità era affidata ad un razionale, quella di magazzino ad un magazziniere, le vendite ad un mercadante.
Degno di nota l'uso della partita doppia con metodo sintetico-riassuntivo che rispecchiava fedelmente le diverse fasi della lavorazione. Il sistema in pratica già denotava un'organizzazione di tipo aziendale. Ben presto, però, si resero necessarie modifiche alla struttura organizzativa e fu nominato amministratore il Cosmi che individuò le responsabilità dei vari settori cointeressando il personale alla manutenzione degli impianti e alla buona riuscita del prodotto.
Cominciò così un lungo processo di responsabilizzazione ed incremento dell'autonomia che passerà attraverso varie crisi legate alle vicende storiche che in quel periodo sconvolsero l'assetto politico europeo. La tessitura fu affidata ad appaltatori esterni con l'obbligo di assicurare il lavoro a tutti i tessitori, secondo salari stabiliti e ritirando le materie prime solo dalle aziende reali.
La rivoluzione francese causò un'interruzione della lavorazione di 3 mesi. Nel 1799 fu istituita la municipalità che entrò in possesso di tutti gli immobili mentre per la fabbrica fu stipulato un contratto di affitto che prevedeva la cessione di tutte le lavorazioni, tranne la filatura che rimaneva al Re.
Successivamente, nel 1806, fu divisa fra 12 soci appartenenti alla comunità oltre il Re e la Cassa di Carità. Fu questa un'ulteriore evoluzione verso una forma associativa di capitali e lavoro.
La Cassa di Carità era un organismo all'avanguardia, strumento di sostegno nei momenti di crisi. Ogni manifatturiere contribuiva in proporzione al proprio guadagno ed aveva la facoltà di votare per il contributo da elargire. Sorta come una specie di mutua, finì per rappresentare il reale patrimonio della Comunità.
Dal 1805 al 1815 il Regno di Napoli passò ai francesi. In un primo momento la Colonia fu assimilata al Comune di Caserta ma i Seniori, i rappresentanti della comunità, l'istituzione leuciana più democratica, riuscirono ad ottenere il riconoscimento della propria autonomia ed integrità patrimoniale. In quegli anni furono varate diverse iniziative agricole e furono completate le fabbriche della parte settentrionale. Si stipularono nuovi contratti di affitto comprendenti anche la filatura; ma soprattutto la Colonia godette della benevolenza di Carolina Bonaparte che richiese le stoffe per l'addobbo delle altre Regge. Il periodo più florido fu, comunque, quello che va dalla sua fondazione fino al 1799. In seguito, a causa della recessione dovuta alle lotte politiche, alle rivoluzioni ed ai continui cambi al vertice della fabbrica, anche San Leucio passò un lungo periodo di crisi durante il quale il Re fu costretto ad intervenire rifondendo sempre nuove quote di capitale. Il momento peggiore della crisi fu raggiunto durante gli avvenimenti rivoluzionari del 1820. Il lavoro scarseggiava, il malumore serpeggiava fra i coloni a causa della disoccupazione che costrinse molti ad emigrare. La produzione rimase invenduta nei magazzini e il peso della concorrenza straniera fu sempre più evidente.
In questo difficile clima fu nominato amministratore il Sancio, il quale riorganizzò la fabbrica riuscendo a risollevarne le sorti.
Introdusse il telaio jacquard, invenzione di J. M. Jacquard, tessitore di Lione, caratterizzato da una semplificazione dell'ingranaggio che, senza la necessità di licci e pedali, poteva eseguire tessuti con armature diverse e soprattutto disegni molto lunghi.
Il meccanismo fu poi perfezionato ed ancora oggi è alla base dei più moderni telai elettronici.
Questo telaio divenne il simbolo di una produzione specialissima che adornava le corti di tutta Europa. Basta scorrere gli Atti Amministrativi dell'ex Intendenza Borbonica per avere un'idea dei generi prodotti: ormesini, organzini, rasi, rasoni, saie, broccati, velluti, zeffiri, casimiri, nobiltà, floranze, levantini, virginie, battiste, mille punti, nenkin, pekin vellutè, reps, crespi scozzesi, thull, persigliè, martelline, danzati, popelines, passamanerie e sete per tappezzeria, paramenti sacri, confezioni di abiti, guarnizioni.
Già dalla prima metà del secolo XIX si produceva inoltre un tipico tessuto per abbigliamento dal caratteristico nome di "Leuceide" con cui si confezionavano i cosiddetti "leuceidi", abiti da donna di maglia a punto di Berlino, di varie taglie e colori, "a tre o quattro ferze" e con bordure variamente ricamate. E, accanto al rinomatissimo Gros de Naples, fioriva una ricchissima produzione di calze di seta ricamate per uomo e per donna, di scialli a maglia e con frangia, di gilet da uomo, di fazzoletti "per sudore" e "per gola", follie da giorno, frivolitès per guarnizioni, tappeti a riccione ed a doppia faccia ed infine la tipica coperta "in seta di San Leucio" che fino a qualche anno fa era capo essenziale del corredo delle giovani spose meridionali.
Anche nella commercializzazione, particolarmente spinosa perché la produzione era proporzionata più ai bisogni della popolazione che alle reali esigenze del mercato, furono introdotte nuove concezioni. Si fittò infatti al Sedile di Porto una bottega e, qualche anno dopo, un negozio nella grande strada di Toledo. Se al principio la produzione rozza e cara non facilitava le vendite, successivamente le cose migliorarono e si aprirono numerosi altri spacci e punti vendita in tutta Napoli e nelle grandi città del Regno delle Due Sicilie.
Anche all'estero il tessuto leuciano ebbe grande riscontro, si vendeva a Londra, Corfù, Tunisi, Tripoli e si hanno notizie di primi contatti con l'America.
Con l'avvicinarsi del 1848, però, le perdite diventarono sempre più sensibili. L'unificazione d'Italia determinò la fine dell'autonomia della Colonia. I beni della Casa dei Borbone divennero beni nazionali. L'Amministrazione fu affidata alla Sopraintendenza così come gli opifici ed ogni cosa vi si trovasse. La fabbrica fu chiusa, gli artigiani persero il lavoro e la Casa Reale fu costretta a sostenerli con sussidi di disoccupazione.
Anche le case degli operai divennero demanio statale e la Cassa di Carità fu inclusa nei beni dei Borbone.
Ancora una volta intervennero i Seniori che deliberarono contro l'aggregazione di San Leucio al Comune di Caserta, richiedendo il ripristino dell'autonomia e il proseguimento della gestione dell'industria. Dopo varie vicissitudini, nel 1866, si concluse definitivamente la storia borbonica della Colonia di San Leucio che resta però un monumento di fondamentale importanza per lo studio dello sviluppo industriale dell'area casertana.
Fortunatamente illuminati imprenditori dell'epoca diedero vita a nuove aziende che continuano ancora oggi a tenere alto il nome di San Leucio nella produzione tessile mondiale che, col passare degli anni, ha trovato nuova linfa nei tessuti d'arredamento: infatti, oggi si producono solo broccati, damaschi, lampassi, liseré e quant'altro destinato all'arredo della casa.
La stessa tradizione serica della mia famiglia si è tramandata per 5 generazioni e molteplici sono state le forniture illustri. Cito, tra gli altri, la Casa Bianca, il Lincoln Center, il Cremlino, Buckingham Palace, l'Eliseo, il Quirinale, Montecitorio, Palazzo Barberini, Palazzo Madama.
Un grosso sviluppo commerciale è sicuramente dovuto alle ultime generazioni. Le attuali tessiture seriche sono mirabilmente riuscite a mantenere inalterato, in molti casi migliorandolo, il tasso di qualità dei prodotti affiancandoli ad un alto grado di tecnologia, elemento ormai essenziale nella modernissima produzione leuciana. A riprova di ciò, purtroppo, sono proliferate da anni copie e plagi dei tessuti.
L'impegno delle attuali generazioni è di tramandare la tradizione dell'arte serica.
Oltre due secoli di ininterrotta operosità, anche nelle mutate condizioni storiche determinatesi lungo il corso del tempo per effetto del diverso assetto sociale e politico, hanno fatto di questa "isola di utopia" una realtà viva e palpitante. Nella quale, anche se il ritmo del lavoro non è più scandito dai colpi lenti e misurati del tradizionale telaio a mano, ma sollecitato dal convulso, incalzante ritmo delle macchine moderne, l'ancora operoso artigiano della seta crea capolavori di un'arte religiosamente appresa dai padri nel lento e naturale susseguirsi delle generazioni.
torna su |