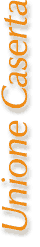
|
 Nonostante
l'adozione di una normativa organica che ha finalmente tratteggiato i
contorni del "modello italiano" di integrazione mediante
l'emanazione del Testo Unico sull'immigrazione e la vivace dinamica dei
movimenti migratori che ha caratterizzato gli ultimi due decenni, la
dimensione della presenza straniera in Italia resta di gran lunga
inferiore a quanto si verifica negli altri maggiori partner europei, sia
in termini assoluti, sia in termini percentuali rispetto alla popolazione
autoctona. Nonostante
l'adozione di una normativa organica che ha finalmente tratteggiato i
contorni del "modello italiano" di integrazione mediante
l'emanazione del Testo Unico sull'immigrazione e la vivace dinamica dei
movimenti migratori che ha caratterizzato gli ultimi due decenni, la
dimensione della presenza straniera in Italia resta di gran lunga
inferiore a quanto si verifica negli altri maggiori partner europei, sia
in termini assoluti, sia in termini percentuali rispetto alla popolazione
autoctona.
Tale osservazione rimane ampiamente vera anche se si considera la quota
degli irregolari, altalenante nel tempo soprattutto in relazione al
succedersi dei diversi provvedimenti di regolarizzazione, ma comunque mai
superiore ad un terzo della presenza complessiva. Invero, il nostro
apparato statistico ha faticato non poco nell'attrezzarsi a registrare i
movimenti relativi alla componente straniera della popolazione.
Ciò precisato, oggi disponiamo comunque di un complesso di dati
sufficienti a descrivere il fenomeno migratorio, un fenomeno che si mostra
in tutta la sua irreversibilità, che sempre più visibilmente modifica il
volto delle nostre città, obbligandole ad interrogarsi sul senso del
concetto di cittadinanza e che fa registrare una sempre più accentuata
contrapposizione tra favorevoli e contrari. In effetti, tale fenomeno
sicuramente presenta sia elementi positivi che problematici. Nella realtà
produttiva soprattutto del nord-est del paese si va, infatti, configurando
un peculiare modello di integrazione, la cui figura tipica è quella
dell'immigrato operaio, impegnato in imprese di piccola e media
dimensione, specialmente del settore metalmeccanico ed edile.
In queste realtà, che associano una situazione di dinamismo economico a
processi di rapido invecchiamento della popolazione, da tempo è stato
segnalato come, accanto al ruolo di copertura delle qualifiche
professionali rifiutate dai locali, la presenza straniera debba adempiere
ad una funzione strutturale, andando a sostituire le leve che via via,
giungono all'età del pensionamento.
In termini complessivi, in un Paese che ha conosciuto negli ultimi anni un
tracollo dei tassi di natalità, l'immigrazione appare destinata a
sopperire alle esigenze di ricambio demografico della popolazione attiva.
E già oggi voci autorevoli, a partire da quella del Governatore della
Banca d'Italia Antonio Fazio, enfatizzano l'aiuto che da essa deriva per
il riequilibrio del sistema pensionistico e contributivo, affetto da
cronici disavanzi. Tuttavia, anche tralasciando di considerare il problema
dell'economia sommersa, la questione della partecipazione degli stranieri
al mercato del lavoro italiano implica una serie di risvolti problematici
finora rimasti offuscati dalla semplicistica equazione "lavori
abbandonati dagli italiani = lavori assunti dagli immigrati".
Basti pensare al fenomeno della dequalificazione della manodopera
straniera istruita. Secondo alcune recenti indagini, infatti, circa il 70%
dei soggetti ad elevata istruzione, immigrati nel nostro Paese, che a loro
volta rappresentano circa un quarto della presenza straniera complessiva,
è colpito da una dequalificazione professionale.
Si tratta, sostanzialmente, di soggetti che si trovano nella
impossibilità di mettere a frutto le loro competenze, mancando modelli o
percorsi sociali cui riferirsi per identificare le tappe di un'ascesa
sociale e professionale. Quanti hanno avuto successo sono ancora troppo
pochi per potere esercitare una reale influenza sugli altri.
L'ipotesi è addirittura che in Italia, contrariamente a quanto si
verifica negli altri Paesi industrializzati, risulterebbe più facile il
processo di integrazione degli immigrati con poca o nessuna qualifica,
piuttosto che di quelli qualificati.
Resta il fatto che chi non si adatta, anche perché non disponibile a
svolgere un lavoro "in nero", rischia una deriva nella devianza,
vissuta come strumento per raggiungere quegli obiettivi che non si è in
grado, o non si e disposti, ad ottenere con i mezzi leciti.
Il problema riguarda, al momento, una nettissima minoranza, caratterizzata
da alcuni attributi che costituiscono altrettanti fattori di rischio.
La maggioranza di immigrati, invece, è rappresentata da giovani maschi,
espatriati individualmente, provenienti da Paesi dell'immediata periferia
europea o comunque da contesti, di tipo sia urbano che rurale, segnati da
processi di degrado economico, sociale e politico. Resta il fatto che la
partecipazione degli stranieri ad attività devianti costituisce un
fattore determinante nell'involuzione dell'atteggiamento degli italiani
verso gli stranieri, involuzione registrata da un quasi tutte le indagini
sul tema.
Più precisamente, siamo passati da una fase di neutralità negli anni
'70, nella quale lo straniero, per lo più studente o rifugiato, stimola
una forte curiosità senza creare aspettative sociali; da una fase di
inconsapevolezza, che copre la prima metà degli anni '80, durante la
quale lo straniero comincia a configurarsi come un potenziale pericolo per
i privilegi goduti dai cittadini; ad una fase di emergenza, che riguarda
la seconda metà degli anni '80, nella quale l'immigrazione viene definita
come problema sociale e come rischio per gli equilibri economici e sociali
preesistenti; fino all'ultima ed attuale fase, quella dell'etichettamento,
nella quale lo straniero si trasforma da problema sociale in problema di
ordine pubblico, da soggetto indesiderato a soggetto socialmente
pericoloso: il suo stereotipo tende a divenire il suo principale elemento
definitorio facendo crescere la distanza sociale.
In sostanza, il tema dell'immigrazione straniera rischia di essere sempre
più strettamente associato a quello della sicurezza urbana.
Questa preoccupazione incide profondamente sulle rappresentazioni
collettive del fenomeno, giungendo a condizionare le iniziative per
governarlo e tutto ciò, paradossalmente, proprio nella fase in cui si
registra una stabilizzazione della presenza straniera, o di una
ragguardevole quota di quest'ultima, in tanti ambiti del nostro tessuto
produttivo e sociale. Nel volgere di pochi anni, dal momento in cui la
società italiana ha preso consapevolezza del fenomeno, al di là delle
contrapposizioni sul tipo di integrazione da promuovere, l'immigrazione è
divenuta un elemento costitutivo della convivenza, in grado di incidere
sul complessivo funzionamento della società ospite. I figli degli
immigrati frequentano gli asili nido e le scuole, e crescono fianco a
fianco degli autoctoni.
E tuttavia sembra, nel complesso, che l'attenzione sia stata e sia più
diretta a cogliere le problematiche dell'emergenza, o comunque della
non-normalità, alimentando una sterile contrapposizione tra lo
schieramento dei pro-immigrati e lo schieramento degli ostili e tradendo
l'incapacità di cogliere le implicazioni di lungo periodo di un fenomeno
strutturale.
La preoccupazione di non urtare la sensibilità degli autoctoni guida le
scelte in materia di programmazione degli ingressi (rimaste finora
sottodimensionate non solo rispetto all'offerta potenziale, ma alla stessa
domanda interna), ostacola perfino l'attivazione delle misure urgenti di
governo del fenomeno (si pensi alle difficoltà incontrate per la
realizzazione dei Centri di permanenza temporanea e assistenza, che pure
devono servire a rendere effettive le tanto auspicate espulsioni),
sospinge le amministrazioni locali a perseguire una strategia di
"invisibilità" nell'offerta dei servizi.
Queste ultime, attualmente interessate da profondi cambiamenti e riforme
che coinvolgono lo stesso ambito delle politiche sociali, sperimentano
come la qualità dell'azione amministrativa dipende dall'efficienza
interna degli apparati. Così, se è vero che l'entrata in vigore del
Testo Unico sull'immigrazione ha segnato uno spartiacque rispetto al
passato, appare ora sempre più evidente come le risposte ai problemi non
si definiscono tanto attraverso nuove norme, quanto attraverso
l'applicazione delle norme esistenti, siano o no specifiche
all'immigrazione. L'esempio più evidente è rappresentato dal lavoro
"nero", la cui diffusione costituisce il principale fattore di
attrazione dell'immigrazione irregolare, nonché il principale fattore di
inefficacia, nel medio-lungo periodo, dei provvedimenti di sanatoria.
Questi ultimi, infatti, sono uno degli aspetti maggiormente censurabili
della produzione normativa e si auspica vengano finalmente rimpiazzati da
incisive iniziative che contrastino il riprodursi dei fenomeni di
irregolarità.
In conclusione, l'immigrazione in Italia continua a profilarsi con un
doppio volto, quello della normalizzazione e delle risposte virtuose, e
quello dell'emergenza che perdura e che si alimenta di eventi drammatici,
come lo stillicidio di profughi che approdano sulle nostre coste.
Due volti che non possono essere confusi e sovrapposti, che reclamano
strategie e politiche con orizzonti temporali differenti ma, soprattutto,
lo sviluppo di una capacità amministrativa nel gestire in modo efficace
ed efficiente quelli che appaiono fenomeni e problemi ineludibili,
attraverso l'emanazione di regole certe e soprattutto applicate con
rigore.
Ai nostri confini esistono esempi autorevoli, come quelli fornitidalla
Francia e dall'Inghilterra, paesi nei quali, nonostante la storica
presenza di marcati nazionalismi, abbiamo potuto assistere ad una
encomiabile integrazione socio-lavorativa.
Certo è che tale capacità amministrativa potrà maturare nella misura in
cui sarà diffusa la consapevolezza di promuovere non solo il concetto
politico di "governo dell'immigrazione", ma altresì una
"cultura dell'immigrazione", intesa come integrazione non solo
lavorativa, ma anche civile, sociale, religiosa e sanitaria, che di tale
concetto rappresentano ingredienti essenziali.
torna su |